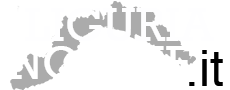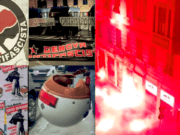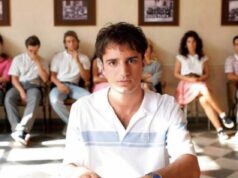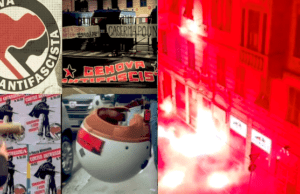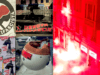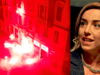Pubblico folto e lunghi applausi venerdì sera alla prima di Cavalleria rusticana
Il debutto dell’opera lirica di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni -Tozzetti e Guido Menasci, avvenne al Teatro Costanzi di Roma il 17 maggio 1890 ed è considerato l’inizio del verismo musicale.
Nel 1884 al Teatro Carignano di Torino La Cavalleria rusticana di Giovanni Verga, con Eleonora Duse nel ruolo di Santuzza, aveva dato inizio al teatro verista. L’editore dovette risarcire Verga a seguito di una causa intentata dallo scrittore, ma l’opera ebbe ugualmente un successo mondiale.
Fine Ottocento: l’azione si svolge in un paese siciliano che si appresta a festeggiare la Pasqua. Alfio, carrettiere benestante (poichè all’epoca era un mestiere lucroso e ricercato), ha sposato Lola, già fidanzata con Turiddu, partito per fare il soldato.
Ma al ritorno di quest’ultimo la passione sopita tra i due ex è riesplosa: Santuzza, la nuova fidanzata di Turiddu, non tollera l’umiliazione, incrementata anche dagli atteggiamenti ironici di Lola, e rivela la relazione ad Alfio, rendendo inevitabile il duello tra i due uomini (il rusticano regolamento di conti) che si concluderà con la morte di Turiddu.
Protagonista di questo dramma, dove nessuno pare comportarsi secondo giustizia o saggezza, è il concetto distorto dell’onore che sovrasta tutti come una nube funesta, padrone della vita dei protagonisti. L’onore che Alfio è costretto a difendere, una volta a conoscenza del tradimento di Lola, sfidando a duello compare Turiddu. L’onore che cerca di recuperare Santuzza, “sedotta” secondo la mentalità del tempo e non sposata, addirittura scomunicata (lei…e non lui) con proibizione di entrare in chiesa. Pare che a nessuno sia chiaro che il disprezzo sociale non va ai traditi ma ai traditori.
Il Turiddu di Mascagni, pur restando un sanguigno “uomo d’onore”, risulta più rispettoso dei sentimenti altrui, cosa che si rivela in pieno quando sente avvicinarsi la fine, di cui è consapevole, sia del dolore che arrecherà alla madre, sia di quello della fidanzata umiliata.
Lola appare come una figura femminile superficiale e sicura di sè, Santuzza ha un temperamento dolente e autopunitivo, anche se, nel disperato tentativo di salvare il rapporto e la rispettabilità sociale, cede alla bassezza della spiata.
L’allestimento del Carlo Felice si apre su uno scenario che invita alla contemplazione; la piazza davanti alla chiesa pronta per la messa di Pasqua ricorda la scena di un teatro antico. Poco dopo assistiamo alle manifestazioni di devozione del popolo, suggestive ma già inquietanti per la presenza di maschere diaboliche, che improvvisamente si animano dando vita ad un balletto dal sapore tribale, presagio dell’incombente tragedia. Perfino la croce che si intravede nella chiesa è sbilenca. Un crescendo potente nella musica e nel testo, portato alla massima drammaticità nel colloquio tra Santuzza e Turiddu e nella conclusione.
Il numeroso coro si impone da onnipresente protagonista, quasi a rappresentare la potenza dei condizionamenti sociali, delle tradizioni e comportamenti imposti che non sempre si allineano all’umanità e al buon senso.
Secondo il commento del temibile critico dell’epoca Eduard Hanslick, “la musica scaturisce dalla situazione, è omogenea, un tutto unico, non ha momenti di stasi; Mascagni, pur essendo profondamente italiano è anche modernamente europeo”.
La musica, ben diretta dal giovane direttore Davide Massaglia, è costantemente padrona della scena: il coro «gli aranci olezzano», la preghiera « il Signor non è morto», «Il cavallo scalpita» di Alfio, lo stornello di Lola «Fior di giaggiolo» che spezza come un intermezzo beffardo il momento drammatico del confronto di Santuzza e Turiddu. Non meno efficaci gli intermezzi verbali: l’urlo finale che annuncia la morte di Turiddu è uno schizzo di sangue sulla platea, ineluttabile conseguenza della maledizione lanciata da Santuzza, “ A te la mala Pasqua, spergiuro”.
Ottime le prestazioni di tutti gli interpreti maschili e femminili, simpatici i mimi e il gruppo dei bimbi.
°°°°°°°°°
La produzione di compositori italiani, Mascagni, Leoncavallo e in parte Puccini adatta al melodramma elementi del verismo, nato come corrente letteraria fra il 1875 e il 1895 e sviluppatosi a Milano, che si propone di rappresentare reali situazioni umane e sociali, soprattutto delle classi considerate più umili e riportandone gli aspetti meno gradevoli e concreti. Si esplorano realtà sociali dell’Italia centromeridionale e insulare. Tra i letterati sono noti Luigi Capuana e Giovanni Verga.Il messaggio trasmesso dalla musica e dalla letteratura è la difficoltà ad uscire da comportamenti imposti dall’ambiente e pesantemente impressi nei tratti psicologici.
Il tratto verista ripreso dalle opere musicali è un ineluttabile scivolo verso la tragedia, un meccanismo che induce all’errore e all’eccesso, di cui si ha una latente consapevolezza ma che non si riesce a fermare. ELISA PRATO
Carlo Felice, torna in scena Cavalleria Rusticana
Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube